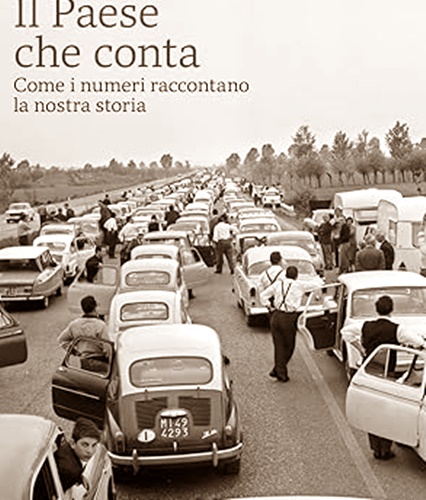Durante il fascismo non era possibile raccogliere e pubblicare dati sulla povertà e sulla criminalità, che pure sarebbero stati, per quanto parzialmente, disponibili, tramite gli enti di assistenza e le questure. Avrebbero smentito la narrazione di un Paese ordinato e tranquillo. Ma non sono solo i regimi dittatoriali a nascondere i dati, o a cercare di manipolarli. Poche settimane fa, Trump ha licenziato la responsabile delle statistiche ufficiali sul mercato del lavoro perché i dati che erano stati pubblicati non corrispondevano alla narrazione del successo della politica aggressiva dei dazi sull’occupazione. La rappresentazione statistica dei fenomeni sociali è una questione cruciale che non riguarda solo gli esperti. È una questione politica, perché che cosa si misura, come lo si misura, se, come e a chi si rendono accessibili i dati costituisce un potente strumento di lettura di ciò che succede in società, quindi di valutazione delle scelte politiche, economiche e sociali che si fanno, dei soggetti, istituzioni, comportamenti meritevoli di attenzione.
Come scrive Linda Laura Sabbadini nel suo libro Il paese che conta (Marsilio), uscito in questi giorni, «misurare significa riconoscere. E ciò che non si misura spesso non entra nelle agende politiche. Non viene visto». Per questo la statistica è una conoscenza guardata con sospetto, o oggetto di tentativi di manipolazione, da parte dei regimi autoritari. L’affidabilità delle statistiche, il rigore metodologico, la trasparenza nei criteri di rilevazione, la verificabilità, dovrebbe essere, ovviamente, una caratteristica normale del lavoro di ogni studioso o istituto di ricerca. Ma, in un paese democratico, devono essere garantite e protette soprattutto quando si tratta di statistiche ufficiali. Perciò va difesa in ogni modo l’indipendenza degli istituti che le producono e garantito l’accesso ai dati a chi vuole utilizzarli. Perché buone, rigorose, complete, statistiche ufficiali sono, come scrive sempre Sabbadini, un bene comune e uno strumento di democrazia.
È una tesi che Sabbadini argomenta in modo appassionato, dove biografia personale e professionale spesso si intrecciano, tracciando la storia dello sviluppo delle statistiche sociali all’interno dell’Istat, dal dopoguerra ad oggi. Una storia che accompagna e documenta in modo sempre più ricco e articolato quella dell’Italia e che ha visto in Sabbadini, con il sostegno di alcuni presidenti dell’Istat disponibili ad allargare lo sguardo al di fuori dell’economia, e la collaborazione con studiosi di varie discipline, una importante protagonista. Sono abbastanza vecchia da ricordare quando gli unici dati disponibili a livello nazionale sulle famiglie erano quelli – ridottissimi – dei censimenti. Analogamente poco o nulla si sapeva sui comportamenti di consumo.
Dagli anni ’80 del secolo scorso e soprattutto in quelli che Sabbadini definisce (per le statistiche sociali) «gli splendidi anni ’90», prima con le Indagini sulle forze di lavoro e sui consumi, poi con il sistema delle Indagini multiscopo, i dati statistici sulla società italiana hanno allargato la nostra conoscenza sulle reti familiari e i rapporti di parentela, la divisione del lavoro interna alla famiglia, le modalità di formazione della famiglia, la salute, i consumi culturali, l’uso del tempo, la partecipazione politica e altro ancora, seguendone i cambiamenti nel tempo. Senza questi dati non sarebbe stato possibile costruire il sistema di indicatori del Benessere equo sostenibile (Bes) che oggi costituiscono un prezioso strumento di monitoraggio della società italiana.
A proposito del fatto che solo che ciò che si misura può diventare visibile ed entrare nel dibattito pubblico, molto importanti sono stati due cambiamenti di prospettiva, che hanno anche modificato il modo in cui si presentano i dati: l’introduzione di una prospettiva di genere, che ha consentito di rendere visibili le donne, i loro comportamenti, esperienze, modalità di collocazione sociale, e la messa a fuoco dei soggetti come individui, anche quando all’interno di una famiglia. Questo doppio passaggio ha reso più articolata la lettura di dati già disponibili nelle indagini “classiche”. Ad esempio non si è più guardato solo all’incidenza della povertà tra le famiglie a seconda della loro composizione, ma anche alla sua distribuzione a seconda delle fasce di età, o del sesso. Soprattutto, ha aperto nuove piste di ricerca. Nascono così le indagini sulla violenza, sulla criminalità, sui bambini e gli adolescenti, sulla mobilità sociale e le disuguaglianze, sugli stereotipi.
Per la sua ricchezza, il libro di Sabbadini 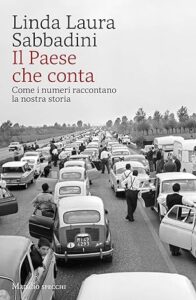 si presta a tre livelli di lettura: una storia della statistica ufficiale e dell’Istituto che ne è responsabile, dell’importanza che ha la solidità e l’indipendenza di questa istituzione, ma anche la capacità di innovazione (si arriva fino alla questione dell’utilizzo dei big data) e in ultima analisi della passione delle persone che in essa lavorano ai vari livelli; una storia sociale dell’Italia vista attraverso i cambiamenti nei modi di fare famiglia, nella struttura per età della popolazione, nei rapporti uomo-donna, nei consumi, nelle forme e gradi disuguaglianza; una autobiografia professionale e umana coraggiosa e appassionata.
si presta a tre livelli di lettura: una storia della statistica ufficiale e dell’Istituto che ne è responsabile, dell’importanza che ha la solidità e l’indipendenza di questa istituzione, ma anche la capacità di innovazione (si arriva fino alla questione dell’utilizzo dei big data) e in ultima analisi della passione delle persone che in essa lavorano ai vari livelli; una storia sociale dell’Italia vista attraverso i cambiamenti nei modi di fare famiglia, nella struttura per età della popolazione, nei rapporti uomo-donna, nei consumi, nelle forme e gradi disuguaglianza; una autobiografia professionale e umana coraggiosa e appassionata.
Chiara Saraceno, La Stampa, 04/09/2025