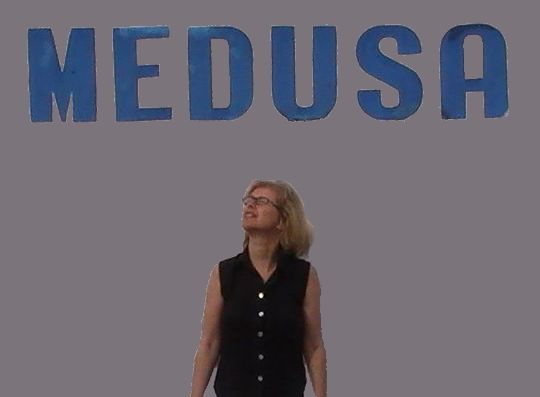Donne e letteratura di, Gloria Gaetano
Inquadrare il rapporto tra donne e letteratura significa perlopiù ascoltare dei silenzi. Poche, infatti – anche se ben forti – sono le voci femminili che si levano nel corso della storia letteraria (e non solo) fino a pochi decenni fa. Sono voci isolate, provenienti da donne che si sottraggono alle rigide regole del sistema letterario maschile grazie ad uno status sociale particolare.
Medea, nella tragedia di Euripide (
Con il Medioevo si affacciano al mondo delle lettere alcune personalità femminili: le religiose Rosvita di Gandersheim (sec. X), autrice di dialoghi drammatici, e Herrada di Landsberg, con il suo compendio figurale Hortus Deliciarum (sec. XII); Maria di Francia, che compone dei lais (racconti in versi), e
Ma la «scalata» all’olimpo delle lettere prende avvio nel Rinascimento, pur se ancora limitata al contesto che orbita attorno alle corti. Ne è ben cosciente Ariosto, che nell’Orlando Furioso, dopo avere reso omaggio a Saffo e aver chiamato gli scrittori «uomini invidiosi», così continua: «Ben mi par di veder che al secol nostro / tanta virtù fra belle donne emerga, / che può dare opra a carte ed ad inchiostro, / perché nei futuri anni si disperga» (xx, vv. 17-20).
Nel Cinquecento si trovano poetesse che scrivono inserendosi nella tradizione del canzoniere petrarchesco, come Veronica Gambara (1485-1550), Vittoria Colonna (1490-1547) e Gaspara Stampa (1523-1554), che i romantici considereranno una novella Saffo; ai poeti erotici dell’antichità, in special modo a Catullo, si rifà Louise Labé (1524-1566), francese di origini borghesi, autrice di sonetti ed elegie e del dialogo Contrasto dell’amore e della follia. La Francia dà i natali anche alle prime narratrici in prosa: di Hélisenne de Crenne è il primo romanzo autobiografico al femminile, Les angoisses douloureuses qui procèdent d’amours (1538); Margherita di Navarra, principessa di Angouléme, firma la raccolta di novelle Heptaméron, (1549) prezioso documento sugli usi amorosi dell’epoca.
Circa un secolo dopo, oltreoceano, si leva la voce della religiosa messicana Sor Juana Inés de la Cruz (16511695), autrice della propria autobiografia, drammaturga e poetessa. Sempre nel sec. XVII Madame de La Fayette, con
Il secolo dei «lumi», con i suoi sconvolgimenti in campo sociale, politico ed economico, vede emergere le donne dalla loro condizione di subalternità e affermarsi soprattutto figure di pensatrici. A Parigi non si contano i salotti letterari animati da donne: apre il secolo quello di Madame de Lambert (autrice fra l’altro, di Riflessioni sulle donne, 1727), lo chiude quello di Madame de Stadi, cui si devono importanti opere di carattere politico-sociale, estetico-filosofico e critico, nonché il romanzo autobiografico Delfina (1802), in cui sono messi in primo piano i pesanti vincoli della condizione femminile. Sulla scena inglese, oltre alle bluestocking – donne che sul calco dei salons parigini, promuovono serate di dibattito cultural-letterario – si affacciano Mary Wollstonecraft Godwin, una delle cosiddette «madri storiche» del femminismo, con il suo Rivendicazioni dei diritti della donna (1792), e Ann Radcliffe (1764-1823), i cui romanzi gotici influenzeranno gli scrittori romantici.
L’emancipazione in campo letterario non va sempre di pari passo con quella sociale e politica; le scrittrici del primo Ottocento conducono vita appartata, distante dalla politica e spesso anche dalla città, ignara delle affermazioni delle prime teoriche del femminismo. Ma le loro opere sono lette da un pubblico femminile e urbano, il primo consumatore del nuovo genere letterario che si va imponendo: il romanzo. Il centro della narrativa «al femminile» è preferibilmente una casa, più spesso una casa di campagna, che fa da contraltare alla città: tra questi due poli si muovono le protagoniste della Austen, Elinor e Marianne in Ragione e Sentimento (1811) o le sorelle Bennett in cerca di marito in Orgoglio e Pregiudizio (1813), così come
In Francia, Amandine-Lucie-Aurore Dupin (1804-1876) crea anch’essa la propria identità letteraria sotto pseudonimo maschile: si tratta di George Sand, amica dei grandi scrittori francesi dell’Ottocento, autrice di numerosi romanzi, da quelli che inaugurano il genere «passionale» – incentrati sulla lotta tra passioni dell’anima e convenzioni sociali – a quelli fortemente influenzati dalla sua adesione al pensiero socialista. Danno voce alla poesia ottocentesca, oltre a Emily Dickinson, Elizabeth Barrett Browning e Christina Rossetti, entrambe legate a due figure di spicco della letteratura inglese dell’epoca, rispettivamente i poeti Robert Browning
Scrittrice, saggista, poeta, collabora con Zanichelli, Le Monnier, Bovolenta, Kairòs.
www.poeticlandestini.blogspot.com
www.dopodinoi.wordpress.com
Fonti
-
G. Gaetano, Storia delle donne, Il Novecento, www.ilmiolibro.it, Ed Simone, Napoli 2008
-
G. Gaetano, Il dibattito vol I II III (Antologia per scuole superiori) ed Le Monnier, Fi 1980-99
-
G. Gaetano, Nuove dimensioni, vo I II III, Le Monnier, Fi 1985-99
-
G. Gaetano, Le donne, vol. unico, Zanichelli Bologna 1990-2007
-
G. Gaetano, I lavoratori, Zanichelli; Gli emarginati, Zanichelli; Gli intellettuali, Zanichelli, Bologna 2000-2008
-
G. Gaetano, La parola come suggestione, Vol Unico, Narrativa poesia Linguaggi, Bologna 2001-2009
-
G. Gaetano, La parola come suggestione, 2 voll, Narrativa e poesie Linguaggi, 2003-2010
-
Gaetano, Saggi su “Filologia e letteratura”, rivista diretta de S. Battaglia e Mazzacurati, Loffredo, Napoli 2003: Realismo e umorismo nella letteratura di Pirandello; Il personaggio nella narrativa; La poesia trobadorica
-
G. Gaetano, Vino cioccolata e jazz, www.ilmiolibro.it
-
Gaetano, Prima che il Domani vada, Kairòs Napoli (silloge poetica), 2010
-
AA.VV., Plurale femminile, antologia poetica. www.ilmiolibro.it, distribuito da Feltrinelli
-
G. Gaetano, Vino cioccolata e jazz, www.ilmiolibro.it
-
Video poesia di Estelle Artiste France su www.trailer.it
-
Dalle lande del sud Videopoesia creata da Eroma di Meglio