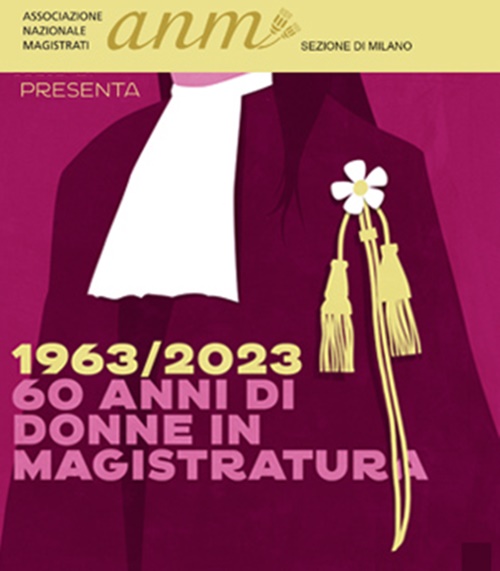1. Celebrare i 60 anni della legge n. 66 del 9 febbraio 1963, che consentì alle donne l’accesso alle funzioni giurisdizionali, impone di ripercorrere un cammino lungo, complesso e pieno di ostacoli.
Come è noto, la posizione delle donne nei confronti della giurisdizione era segnata dall’art. 7 della legge 17 luglio 1919 n. 1176. Tale legge, che pure costituì una tappa importante nel cammino verso il riconoscimento dei diritti delle donne, tra l’altro abrogando l’istituto dell’autorizzazione maritale e riconoscendo loro piena capacità giuridica, le escluse, salva diversa espressa previsione normativa, dalle professioni e dagli impieghi implicanti poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato, secondo la specificazione da effettuare con apposito regolamento. Il regolamento di attuazione 4 gennaio 1920, n. 39 ridusse enormemente gli spazi delineati dalla legge n. 1176, indicando una lunga serie di importanti pubblici uffici preclusi alle donne, tra i quali quelli di prefetto, diplomatico, direttore generale presso ogni dicastero, ministro, ufficiale giudiziario, cancelliere, magistrato, sia della giurisdizione ordinaria che amministrativa e contabile, e conferendo alle amministrazioni statali la facoltà di prevedere ulteriori eccezioni.
Nonostante la dottrina più illuminata avesse percepito nella legge n. 1176 del 1919 l’inizio di un processo inarrestabile che avrebbe permesso alle donne di accedere a tutti gli impieghi pubblici, compresa la magistratura, avendo esse già ottenuto di poter esercitare la professione forense, l’avvento del fascismo, con la sua ossessiva esaltazione del ruolo essenziale della donna all’interno della famiglia e la parallela marginalizzazione della sua funzione nel settore pubblico, impresse una brusca direzione in senso contrario a tale percorso.
Coerentemente con il disposto dell’art. 7 della citata legge del 1919, la disciplina sull’ordinamento giudiziario di cui al r. d. 30 gennaio 1941, n. 12, all’art. 8, n. 1, poneva tra i requisiti per l’ammissione alle funzioni giudiziarie l’essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F. Quindi la non appartenenza alla categoria del maschio italico e fascista precludeva inesorabilmente la possibilità di essere magistrato.
In questo quadro di riferimento, ma in un contesto sul piano politico e sociale profondamente cambiato dopo la caduta del regime, l’Assemblea Costituente affrontò la questione cruciale della possibilità per le donne di accedere a tutti gli uffici pubblici, ed in particolare alla magistratura, ed alle cariche elettive.
La lettura dei resoconti delle sedute di detto consesso offre un quadro desolante, in quanto da quei documenti emerge con evidenza l’atteggiamento di sufficienza, talvolta di insofferenza e di arroganza, della grande maggioranza dei Padri Costituenti nei confronti della possibilità di accesso delle donne agli uffici pubblici ancora preclusi, e in particolare alle funzioni giurisdizionali. Le opinioni sostenute da molti di essi appaiono impregnate di pregiudizi, stereotipi e triti luoghi comuni fortemente ancorati alla cultura del passato, con i quali dovette confrontarsi lo straordinario impegno profuso dalle poche donne presenti nella Costituente nel tentativo di scalfire quella tenace barriera oppositiva (soltanto 21 su 566 erano state elette e soltanto 5 fecero parte della Commissione dei 75 incaricata di predisporre il testo della Carta; nessuna fu chiamata a comporre il “ Comitato di redazione”, che aveva il compito di elaborare il testo votato dalla Commissione).
Dalla piena concordanza di tanti interventi di segno negativo si intuisce che non si trattò di voci isolate, ma di posizioni ampiamente condivise che riflettevano orientamenti e preconcetti profondamente radicati nella classe politica, tra gli operatori del diritto e nella società.
Rinvio chi ne fosse interessato alla diretta lettura dei resoconti ufficiali, che con drammatica chiarezza fanno emergere la miopia e la limitatezza di molte delle opinioni espresse in quel consesso e consente di riscontrare come i principi di democrazia, di eguaglianza, di pluralismo pur reiteratamente evocati dagli stessi Costituenti non riuscissero ad intaccare l’ ideologia dominante nei confronti delle donne e ad indurre quegli insigni giuristi a guardare lontano, piuttosto che appiattirsi su un’ asfittica conservazione dell’esistente.
Giustamente Maria Federici nella fase finale della discussione sull’art. 98 (poi divenuto art. 106) si chiedeva come fosse possibile che quegli stessi Costituenti che in una confluenza di idealità e di visioni avevano sancito nell’art. 3 la pari dignità sociale e l’eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge potessero assumere posizioni così pesantemente discriminatorie nei confronti della metà della popolazione.
Ed è sorprendente constatare che personalità così illuminate non percepirono la gravità dei pregiudizi che annebbiavano il loro pensiero, impedendo di vedere che proprio quei principi di eguaglianza, pari dignità e solidarietà solennemente sanciti nei primi articoli della Carta erano stati offesi in passato in infiniti modi da una legislazione che aveva relegato le donne ai margini della vita sociale, del mondo del lavoro e all’ interno della famiglia e che la sede costituente offriva un’occasione storica irrinunciabile perché quei valori e quei principi si traducessero finalmente nel riconoscimento dei diritti delle donne.
All’ esito di un lungo dibattito, segnato dagli accorati e inascoltati interventi delle Madri Costituenti on. Federici, Mattei e Rossi, si giunse all’ approvazione dell’art. 51, che nel suo primo comma dispone che tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge: una formulazione di compromesso accettata nel diffuso e non dichiarato convincimento che la mancanza di un disposto specifico avrebbe consentito ad ogni interprete di far prevalere la propria opzione ermeneutica.
In effetti l’ auspicio che l’art. 51 Cost., nonostante la sua ambigua formulazione, potesse dare soluzione positiva al problema delle donne in magistratura fu purtroppo vanificato dalla posizione successivamente assunta da vari accademici e dalla giurisprudenza prevalente sul significato da attribuire all’ inciso secondo i requisiti stabiliti dalla legge, e quindi sul rapporto tra detto art. 51 e l’ art. 3 Cost.
Il tenore letterale della norma fornì infatti argomento alla posizione di coloro che optavano per il riconoscimento al legislatore ordinario del potere di prevedere il genere maschile tra i requisiti attitudinali per l’accesso a determinati uffici pubblici e cariche elettive, nell’assunto che quella formula autorizzasse a derogare per via normativa al principio generale di cui all’ art. 3, primo comma. Si richiamavano al riguardo gli artt. 37, primo comma, e 97, primo (ora secondo) comma, Cost., lì dove il primo prescriveva che le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della essenziale funzione familiare delle donne, mentre il secondo sembrava dare spazio alla possibilità che il buon andamento della pubblica amministrazione prevedesse la possibilità di esclusione di personale di sesso femminile.
La dottrina più illuminata mise in evidenza l’inaccettabilità di tale opzione ermeneutica, sul rilievo che l’art. 51 era chiaramente diretto a garantire l’eguaglianza dei cittadini e a negare ogni rilevanza al criterio del sesso nell’accesso ai pubblici impieghi e alle cariche elettive – come peraltro era immediatamente desumibile dalle parole di apertura Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso…-, così ponendo un preciso limite al potere discrezionale del legislatore. Si sottolineava altresì al riguardo l’inconferenza del richiamo all’ art. 37, primo comma, non potendo trarsi da una disposizione posta a tutela della donna lavoratrice, cui venivano riconosciuti gli stessi diritti del lavoratore, argomenti a sfavore del suo accesso a determinati uffici. Ed anche il riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione garantito dall’art. 97 risultava fuorviante, in quanto fondato su una arbitraria presunzione assoluta di inadeguatezza, per ragioni fisiologiche, del genere femminile alle pubbliche funzioni.
Alla posizione più retriva si allinearono i vertici della magistratura, nella loro implacabile contrarietà alla presenza delle donne nell’ordine giudiziario e nell’anacronistica difesa del mito della superiorità maschile, ribadendo il loro convincimento che la parificazione dei sessi prevista nella Costituzione non poteva considerarsi assoluta, in quanto era la stessa Carta a consentire al legislatore ordinario di introdurre, se del caso, eccezioni a tale principio.
Ne derivò che l’accesso delle donne alle carriere elencate nel richiamato regolamento del 1920 rimase per lungo tempo interdetto.
Con la sentenza n. 33 del 1960 la Corte Costituzionale, accogliendo l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato, dichiarò l’illegittimità dell’art. 7 della legge n. 1176 del 1919, nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicassero l’ esercizio di diritti e di potestà politiche, in riferimento all’ art. 51, primo comma, Cost., per l’irrimediabile contrasto in cui detta norma si poneva con l’ enunciato costituzionale. In tale pronuncia il giudice delle leggi interpretò la formula ellittica contenuta nel primo comma dell’art. 51 Cost. nell’unico modo consentito dall’art. 3, ossia intendendo l’art. 51 come una specificazione, e prima ancora una conferma, dell’art. 3.
In questa sua capacità di riconoscere la natura inviolabile ed il valore supremo del principio di eguaglianza vanno colti la carica innovativa e lo spessore culturale, oltre che il valore tecnico, di detta decisione, pronunciata in un tempo in cui erano ancora forti nella società e nel mondo giuridico le diffidenze ed i pregiudizi che avevano animato il dibattito in seno all’ Assemblea Costituente.
Attesa la portata limitata della dichiarazione di incostituzionalità, si dovette introdurre una specifica legge, la n. 66 del 1963, che consentì l’accesso a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, ed abrogò espressamente la legge n. 1176 del 1919 ed il successivo regolamento. Come è stato correttamente osservato in dottrina, il fatto che si fosse resa necessaria una legge ordinaria per ribadire principi già sanciti in Costituzione costituisce chiara conferma della persistente arretratezza culturale degli apparati chiamati ad applicare i principi della Carta.
Al momento dell’approvazione della legge n. 66 del 1963 erano trascorsi tre anni da quella fondamentale sentenza della Consulta; dall’entrata in vigore della Costituzione erano trascorsi quindici anni e si erano svolti ben sedici concorsi per uditore giudiziario, con un totale di 3127 vincitori, dai quali le donne erano state indebitamente escluse. E non può fondatamente contestarsi che il grave ritardo nell’ingresso delle donne in magistratura sia stato almeno in parte determinato dall’ambiguità della formula adottata nell’art. 51, che fornì un facile appiglio alle tesi più reazionarie.
La nuova disciplina sull’accesso rese necessario riaprire i termini di un concorso già bandito nell’agosto del 1962, ma nessuna donna superò quella prova.
Con d.m. del 3 maggio 1963 fu bandito un nuovo concorso aperto alla partecipazione delle donne; con d.m. del 5 aprile 1965 le prime otto donne vincitrici dell’esame entrarono a far parte dell’ordine giudiziario. Io ero una di loro.
2. Da quel primo concorso l’accesso delle donne nell’ordine giudiziario ha registrato nel primo periodo dimensioni modeste, pari ad una media del 4-5 % per ogni concorso, per aumentare progressivamente intorno al 10-20 % dopo gli anni settanta, al 30-40% negli anni ottanta e registrare un’ impennata negli anni successivi, sino a superare ormai da tempo la metà dei vincitori. Attualmente le donne in servizio hanno raggiunto la percentuale del 56% ed è facile previsione che diventeranno sempre di più, tenuto conto che il numero di donne vincitrici di ogni concorso è dal 1987 di gran lunga più elevato di quello degli uomini.
A fronte di tali evidenze mi sovvengono le incaute riflessioni dell’on. Conti nella seduta dell’Assemblea Costituente del 15 novembre 1947, quando affermò che le donne potranno entrare in Magistratura, ma non ci entreranno: questa è la mia convinzione… Se potranno entrare ed entreranno, bene saranno applicate alla Magistratura dei Minorenni . Credo che questa sarebbe un’applicazione utilissima. Si può pensare ad un’ altra applicazione utile: ai servizi di cancelleria.
Alla plateale mancanza di lungimiranza di tale previsione si contrappone una realtà che potrebbe presto portare ad affrontare i problemi di pari rappresentanza al contrario, a seguito di una eccessiva femminilizzazione della magistratura.
Le donne oggi entrano a far parte dell’ordine giudiziario in un contesto sociale e culturale del tutto diverso da quello del 1965 e degli anni immediatamente successivi: in effetti non fu facile per le magistrate negli anni sessanta e settanta ottenere il rispetto dei colleghi, in quanto in molti ambienti anche autorevoli si continuava a porre la domanda se le donne, con le loro specificità fisiche e psichiche, fossero idonee ad esercitare le funzioni giurisdizionali. Si trattava di far fronte non tanto a discriminazioni dirette, quanto a latenti pregiudizi, a malcelate diffidenze, spesso mascherate da inopportuni atteggiamenti paternalistici, chiaramente stridenti con il modello paritario.
La lunga esclusione subita e la percentuale così esigua di vincitrici dei primi concorsi rese inevitabile assumere una posizione di totale omologazione al modello maschile, unico modello di riferimento ed unico strumento per superare pregiudizi e diffidenze ed ottenere piena legittimazione. La completa imitazione ed introiezione di quel modello comportava da un lato la necessità di vivere in modo colpevolizzante i tempi della gravidanza e della maternità come tempi sottratti all’ attività professionale, dall’altra la rinuncia a tracciare per se stesse uno stile, un approccio al lavoro, un linguaggio, delle regole comportamentali sui quali costruire una figura professionale autonoma di magistrata. Si poneva inoltre l’esigenza aggiuntiva di dimostrare in ogni momento ed in ogni contesto lavorativo che la nostra ammissione all’ esercizio della giurisdizione era meritata, con la consapevolezza che il minimo errore avrebbe fatto riemergere una montagna di pregiudizi non totalmente rimossi e avrebbe ricacciato tutte le donne all’ indietro, condannandole ad un giudizio irrevocabile di incapacità. Questo richiedeva di mostrarsi sempre preparatissime, di non sbagliare mai, di non mancare mai alle aspettative dei colleghi, di essere disponibili ad ogni esigenza dell’ufficio: e tale richiesta aggiuntiva si risolveva in una forma di discriminazione indiretta.
Ben presto tuttavia, con la progressiva acquisizione di esperienza e sicurezza, l’appiattimento su quell’unico canone di riferimento cominciò per molte di noi a non essere più appagante, in quanto consentiva di diventare dei buoni giudici, ma finiva con il soffocare, fino a renderla invisibile, l’autonoma significazione di essere donne.
La grande stagione delle riforme degli anni settanta, segnata dall’approvazione di leggi importanti che avrebbero inciso profondamente nella cultura, nel costume, nelle relazioni personali e nel tessuto sociale e l’ emergere anche in Italia del movimento femminista, con tutta la sua carica innovativa in direzione della autonomia e della libertà delle donne, contribuirono certamente a far maturare il convincimento che l’essere donna non era un ostacolo da superare, ma un modo specifico di essere magistrato e che la presenza femminile nell’ordine giudiziario integrava la risorsa di sensibilità e prospettive differenziate nelle questioni da giudicare, e quindi un arricchimento della giurisdizione.
Si trattava allora di coniugare il rigore scientifico del giurista con la specificità dell’essere donna, rivendicando il diritto di interpretare le norme nel rispetto dei canoni della differenza.
In questa direzione è stato forte l’impegno ad assumere un modello di magistrato che non negasse, ma riflettesse la nostra appartenenza di genere e si desse carico di portare nelle camere di consiglio, nelle sentenze e nelle requisitorie lo sguardo, la cultura, la sensibilità e il linguaggio delle donne, ponendo tali profili a confronto con i valori espressi dal mondo maschile, in termini di positiva dialettica.
Nella mia lunga esperienza di giudice ho tante volte avuto occasione di riscontrare, e non solo nella materia del diritto di famiglia e dei diritti fondamentali, come il fatto di essere donna potesse influenzare la valutazione dei fatti e delle prove e portasse a soluzioni giurisprudenziali difformi rispetto ad orientamenti consolidati e più vicine alle esigenze dei soggetti deboli, a valutare da una diversa prospettiva situazioni ed interessi coinvolti nel processo, ad utilizzare diversi topoi argomentativi, a sollevare con particolare convinzione questioni di costituzionalità di norme discriminatorie ancora presenti nel nostro ordinamento.
Guardare le vicende processuali da una prospettiva di genere vuol dire far emergere tutte le forme di discriminazione, da quella che trae origine dall’uso spesso inconsapevole degli stereotipi a quella che trova espressione nell’uso corrente della lingua italiana fino a tutti i segnali di sessismo che attraversano le relazioni umane e i mezzi di informazione e che molti non vedono.
3. Le donne oggi esercitano la giurisdizione in tutti gli uffici giudiziari e svolgono ogni tipo di funzione, ma la loro consistenza numerica non esclude che all’ interno dell’ordine giudiziario si ponga un problema di pari opportunità: le percentuali di donne che ricoprono incarichi direttivi, pur in netta crescita rispetto al passato ( mi limito in questa sede a ricordare che nel 1996, a più di 30 anni dall’ingresso in magistratura, solo 10 incarichi direttivi sui 725 in pianta organica erano ricoperti da donne ), sono ancora ben lontane, specie nell’ambito degli uffici requirenti ( dove raggiungono la percentuale del 23,1%), dal riflettere la composizione per genere della magistratura, come i dati forniti nella nota di presentazione di questo incontro mettono in luce. Ed anche la recentissima nomina di Margherita Cassano a Primo Presidente della Corte di Cassazione, la prima volta per una donna, pur costituendo un passo fondamentale nel cammino verso la parità e pur rivestendo un forte valore simbolico, è solo la tappa di un percorso, perché altri tabù restano da abbattere e soprattutto perché questa nomina non scalfisce il dato della insufficiente presenza femminile ai vertici degli uffici.
Quanto alla partecipazione delle donne all’ organo di autogoverno, si tratta di una storia di gravissima sottorappresentanza. Basti considerare che per la prima volta è stata eletta una togata, Elena Paciotti, nel 1986, a oltre 20 anni dall’ingresso delle donne in magistratura; negli anni successivisi si sono succedute consiliature contrassegnate dall’assenza totale di magistrate o da sparute presenze, sino ad arrivare all’ elezione di una sola donna nella tornata del 2014. Ed anche il risultato dell’ultimo appuntamento elettorale, che ha visto elette 6 donne togate su 20, non può considerarsi appagante e vale a dimostrare l’inadeguatezza delle misure previste nella recente riforma Cartabia a garantire un effettivo riequilibrio della rappresentanza.
Dobbiamo pertanto prendere atto che esiste tuttora in magistratura un glass ceiling da sfondare ed uno sticky floor da rimuovere. E dobbiamo contrastare la posizione di molti colleghi, anche tra i più progressisti, ed anche di molte colleghe, che minimizzano il problema e si trincerano dietro il mantra dell’eguaglianza formale, che ovviamente non è in discussione, ricordando loro che arroccarsi sul principio di eguaglianza formale, e quindi su un malinteso concetto di parità che non conosce differenze, vuol dire non solo negare la specificità dell’apporto delle donne alla giurisdizione, ma anche non comprendere che ciò che viene in gioco è l’eguaglianza sostanziale, la quale si realizza soltanto con la partecipazione effettiva e paritaria di donne e di uomini ad ogni livello di responsabilità, e che tale partecipazione paritaria è una necessità democratica, e non un optional.
Ed è qui che si trova risposta alla domanda sul perché sia così importante che la presenza femminile sia una componente ordinaria, e non eccezionale, della giurisdizione a tutti i livelli.
A quelle posizioni ferme all’ astrattezza ideologica dell’eguaglianza formale è necessario opporre la rivendicazione del valore della differenza, cercando di dimostrare che al di là del simulacro dell’eguaglianza formale va riconosciuta l’ iniquità della sottorappresentanza delle donne, così come va apprezzata, e non negata, la ricchezza di uno scambio fecondo di punti di vista e di sensibilità diverse, che possono illuminare aspetti di realtà che altrimenti rischierebbero di rimanere nascosti. La battaglia contro la discriminazione si combatte nel nome della rivendicazione della differenza, non della sua negazione.
Deve essere pertanto contrastato il diffuso convincimento che sia del tutto indifferente il genere di appartenenza del magistrato chiamato a giudicare una controversia civile o a comminare una condanna penale o a condurre un’indagine o a dirigere un ufficio giudiziario.
So bene che la necessità di ricercare diversi modelli professionali non è da tutte le donne condivisa, perché non tutte le donne sono eguali e non tutte fanno e faranno la differenza: è sempre forte in alcune la tentazione di farsi ammettere o di rimanere nel club maschile come uomini onorari, mascherando la propria femminilità e quindi l’appartenenza ad un genere ritenuto inferiore. Si tratta a mio avviso di atteggiamenti miopi e autolimitanti, atteso che tanto più la presenza delle magistrate sarà importante quanto più esse sapranno rivendicare la loro specificità e autonomia di pensiero liberando gli organi giurisdizionali dai molti stereotipi che ancora li condizionano e così elaborando una visione più alta, più complessa e più equa del sistema di valori tutelati dall’ordinamento.
Non posso al riguardo non ricordare che sempre più numerose sono le sentenze di condanna dell’Italia da parte della Corte EDU per i molti pregiudizi sessisti e i molti stereotipi sulle donne e sul loro ruolo sociale che inficiano il ragionamento giuridico nella valutazione delle prove e nella decisione finale in relazione a processi per violenza sessuale e di genere.
Va inoltre purtroppo riscontrato che in Italia non si è operato abbastanza in questa direzione: i c.p.o. non sempre sono riusciti a mio avviso ad alimentare un rinnovamento culturale nella magistratura, limitandosi spesso ad assumere iniziative meramente sollecitatorie o organizzative a livello locale e non impegnandosi a promuovere e monitorare l ‘ integrazione della dimensione di genere nell’esercizio della giurisdizione.
Concludo ricordando che l’unico modo per superare gli ostacoli che rendono più difficile il percorso professionale delle donne consiste nel dotarsi di una professionalità elevatissima, di un impegno straordinario e costante, senza il minimo cedimento, di una preparazione di eccezionale livello, nutrita da un lavoro incessante di aggiornamento. Perché è ancora purtroppo vero che le donne devono fare di più per essere percepite come uguali.
Il cammino da compiere per vincere archetipi culturali resistenti al cambiamento è ancora lungo e deve tendere ad una sintesi tra eguaglianza, che è concetto tecnico-giuridico, e differenza, che invece attinge alla filosofia, alla psicologia, alla sociologia e alla cultura in generale e che non si oppone all’ eguaglianza, ma ne arricchisce il contenuto. E mentre sull’ eguaglianza il dibattito, in un ordinamento democratico, non dovrebbe neppure aver ragione di essere posto, la differenza è tema affidato alla nostra riflessione e alla nostra elaborazione teorica.
E dobbiamo tutti tener presente che quelle di cui oggi discutiamo sono questioni che non riguardano le donne, ma la magistratura di oggi e quella del futuro e sono dirette a segnare il tasso di democrazia dell’istituzione.
*Testo rielaborato dell’intervento svolto al convegno sul tema 1963-2023, 60 anni di donne in magistratura organizzato dalla sezione milanese dell’ANM presso l’ Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano l’ 8 marzo 2023.
di Gabriella Luccioli
pubblicato su GIUSTIZIA INSIEME